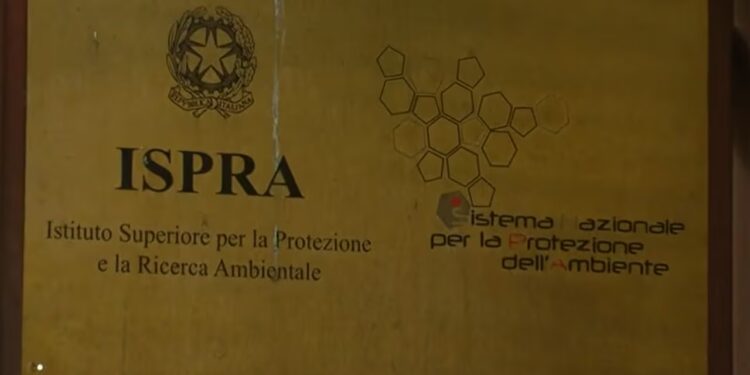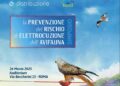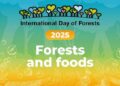Direttiva “Uccelli”
I cieli italiani sono attraversati da circa 500 specie di uccelli. Alcune di esse sono stanziali altre migratrici, alcune nidificano nel nostro paese mentre per altre l’Italia è solo un ponte di terra che li porta verso le regioni riproduttive del nord. Una comunità ecologica di milioni di individui fondamentale per gli equilibri biologici del pianeta e che connette aree e continenti, a volte, lontanissimi tra loro. L’avifauna, come parte della fauna selvatica, è “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale secondo” come chiarisce la legge nazionale 157 del 1992, che regola il prelievo venatorio. La Direttiva “Uccelli” nello specifico impone che il prelievo venatorio delle specie presenti nell’allegato II rispetti il principio di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie, senza pregiudicarne pertanto lo stato di conservazione.
Ricerca di un equilibrio
La ricerca di un equilibrio tra conservazione, tutela, vitalità delle popolazioni di specie ornitiche e pressione venatoria avviene, in Italia, tramite i calendari venatori che, su base regionale, regolamentano l’attività venatoria, stabilendo, su base analitica, le specie cacciabili e i limiti dei carnieri, le giornate, i limiti orari e i periodi dell’anno in cui la caccia è consentita. Per esercitare l’attività venatoria, oltre al porto d’armi, alla licenza di caccia ed essere iscritti ad un ambito territoriale di caccia ATC, è necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato ogni anno dal comune di residenza del cacciatore che si deve attenere alle quantificazioni del prelievo per specie espresse dal calendario venatorio regionale. Il tesserino venatorio autorizza l’attività di caccia per una stagione e va rinnovato di anno in anno. I dati dei tesserini venatori, che contengono informazioni sulle giornate di caccia e il numero abbattimenti per specie, vengono aggregati su base regionale e comunicati ad ISPRA che successivamente redige un rapporto sul prelievo faunistico nazionale, in cui viene analizzata l’influenza del prelievo venatorio sulle popolazioni delle specie cacciabili. Pertanto, ogni anno, Regioni e Province Autonome devono trasmettere i dati di abbattimento che, una volta elaborati da ISPRA, saranno inoltrati dal MASE alla Commissione europea.
I dati per le stagioni venatorie dal 2017 al 2023
Sono stati analizzati i dati pervenuti a ISPRA entro il 31 ottobre 2024 relativi al numero di abbattimenti di ciascuna specie ornitica cacciabile nel periodo compreso tra la stagione venatoria 2017-2018 e quella 2022-2023; la quantificazione degli abbattimenti costituisce, di fatto, la prima informazione necessaria alla valutazione dell’entità del prelievo venatorio in Italia. A questa data le informazioni sui tesserini venatori relativi alla stagione venatoria 2023-24 erano state trasmesse solo da cinque regioni (Abruzzo, Campania, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta), per cui nella presente relazione questa stagione venatoria non è stata considerata. L’Umbria è l’unica regione che non ha mai trasmesso i dati per le stagioni venatorie considerate in questa rendicontazione. Le informazioni inviate dalle diverse regioni relative al rapporto tra tesserini analizzati sul totale dei tesserini rilasciati in ogni singola regione, fondamentale per analizzare il reale peso del prelievo venatorio, risultano, sulla base di quanto inviato, decisamente carenti per tutte le stagioni venatorie considerate nel presente report, in quanto soltanto per poche regioni risulta espresso in modo chiaro questo fondamentale parametro. Dal report emerge che i dati non permettono di avere un quadro completo sul prelievo venatorio per le stagioni analizzate. La sola regione Campania ha trasmesso questo dato per tutte le stagioni venatorie considerate. Le percentuali di tesserini analizzati sono variate in questa regione tra il 52% e il 78% nelle diverse stagioni venatorie trattate in questo report.
Tordo bottaccio: il più cacciato d’Italia
La specie più cacciata in Italia in tutte le stagioni venatorie è il tordo bottaccio (Turdus philomelos) della famiglia dei Turdidi. Questa specie canora è caratterizzata da taglia medio picciola ed ampia diffusione. L’adulto presenta la parte dorsale del corpo di colore bruno, mentre la parte ventrale è color bianco-crema con ampie picchettature di nero ed il caratteristico sottoala fulvo giallastro. Famoso per il suo canto melodioso (da cui il nome specifico philomelos = amante della melodia), è monogamo e, durante il periodo riproduttivo, molto territoriale. È una specie migratrice, con un homing caratteristico in quanto frequenta le stesse aree di svernamento e di nidificazione per tutta la vita. La migrazione di questa specie avviene di notte, spesso a quote elevate, accompagnata dall’emissione di un caratteristico verso, detto, onomatopeicamente, zirlo. La sua dieta varia durante l’anno, divenendo più insettivoro durante la stagione riproduttiva e maggiormente frugivoro durante il restante periodo. La stagione riproduttiva ha inizio in marzo nell’Europa occidentale, e circa un mese dopo nell’Europa centrale e orientale. Nidifica in una grande varietà di habitat, in cui comunque è indispensabile la presenza di alberi e cespugli. La caccia a questa specie è strettamente collegata alle tradizioni venatorie e agli habitat presenti nelle varie regioni. Il Tordo bottaccio, ad esempio, è molto cacciato in Lombardia e Veneto dove viene abbattuto da appostamenti fissi realizzati per la caccia alle specie migratrici diffusi su tutto il territorio regionale.
Il fagiano comune e le immissioni
Tra i non Passeriformi il fagiano (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758), appartenente all’ordine dei Galliformi, è una delle specie più interessate dall’attività venatoria. Nativo dell’Asia e di alcune parti dell’Europa (area del Caucaso e dei Balcani), è stato introdotto nel mondo per il grande interesse a fini venatori. La quantità del prelievo è fortemente condizionata dalle numerose immissioni effettuate a scopi venatori.
Il Colombaccio, da nomade a stanziale
Un’altra specie non Passeriforme molto cacciata nelle diverse regioni italiane è il colombaccio (Columba palumbus). Appartenente alla famiglia dei Columbidi ha uno stato di conservazione favorevole, caratterizzato da un incremento demografico in tutto il territorio nazionale. Tradizionalmente migratore, negli ultimi decenni importanti popolazioni sono diventate stanziali in diverse parti dell’areale meridionale di questa specie, tra cui anche l’Italia, in cui in passato era principalmente presente come svernante e di passo.
La tortora selvatica
La tortora selvatica (Streptopelia turtur), appartenente alla famiglia dei Columbidi, è caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole che ha indotto la CE a chiedere in anni recenti l’interruzione della caccia agli stati membri. Per questa specie ISPRA, su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha elaborato il piano di gestione nazionale che è stato approvato dalla conferenza Stato Regioni a seguito di interlocuzioni con le regioni.
L’alzavola
Tra gli anatidi le due specie più cacciate sono il germano reale Anas platyrhynchos e, la più piccola alzavola (Anas crecca). Tra le specie di anatidi, nel 2023 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano di gestione del moriglione (Aythya ferina) finalizzato alla conservazione e la gestione delle popolazioni italiane nidificanti di questa specie e dei contingenti migratori che attraversano e/o svernano nel nostro Paese. L’Alzavola, come il germano reale e molti altri anatidi, ha uno spiccato dimorfismo sessuale con il maschio che mostra una colorazione più appariscente (foto di Alberto Sorace ISPRA)
L’allodola e lo specchietto
Tra i Passeriformi, escludendo le varie specie appartenenti alla famiglia dei turdidi, l’allodola (Alauda arvensis) è la specie per la quale si registrano gli abbattimenti più cospicui a livello nazionale. L’Allodola è un passeriforme appartenente alla famiglia degli Alaudidi. Ha dimensioni piuttosto piccole e, in entrambi i sessi, la parte superiore si presenta di color marrone con leggere striature di nero mentre nella parte inferiore appare di un marrone più chiaro. Il suo comportamento condizionava le tradizionali modalità di caccia, che si svolgevano con l’ausilio di “fischietti”, che, sfruttando la gregarietà della specie, portavano i branchetti ad avvicinarsi al cacciatore ben nascosto nei pressi di “zimbelli”, solitamente una civetta meccanica e un richiamo girevole formato da due braccia munite di specchietti. Le allodole accorrevano attorno agli zimbelli per curiosità o per mettere in atto il mobbing, comportamento gregario utilizzato per proteggersi dagli uccelli rapaci. Da questo comportamento deriva il detto “specchietto per le allodole”, per indicare che alcune cose allettanti, ammalianti e cariche di potere attrattivo, nascondono invece inganni e insidie, rivelandosi dei trabocchetti per raggirare gli ingenui. Lo stato di conservazione dell’allodola in Europa è allarmante in quanto la specie ha mostrato un marcato decremento di popolazione a livello europeo, come è attestato dai dati raccolti per l’elaborazione del Farmland Bird Index.
Variazioni anche considerevoli
Le quantità di abbattimenti riportati per le diverse specie considerate mostrano variazioni anche considerevoli tra le diverse realtà territoriali regionali e ciò può essere ricondotto, sia all’incompletezza dei dati forniti da alcune regioni che a differenze nelle consuetudini venatorie (maggior interesse verso alcune specie rispetto ad altre, prevalenza di un metodo di prelievo rispetto ad un altro); possono inoltre aver giuocato un ruolo importante differenze nelle rotte di migrazione e cambiamenti dell’areale di svernamento delle specie, anche in relazione ai cambiamenti climatici, che determinano la distribuzione e l’abbondanza delle specie nelle diverse aree geografiche del Paese. Ai dati ufficiali di abbattimenti provenienti dall’attività venatoria sono da aggiungere quelli illeciti legati al bracconaggio che, in taluni casi, appaiono incidere significativamente sulle popolazioni di alcune specie ma che sono di difficile quantificazione.