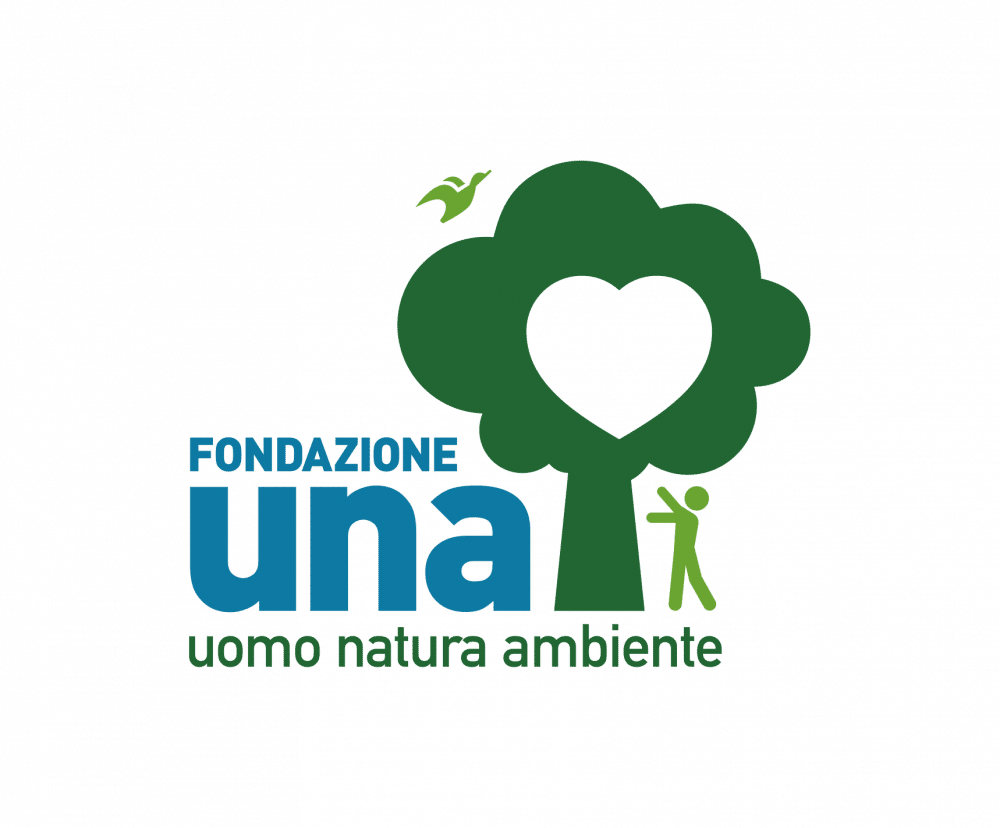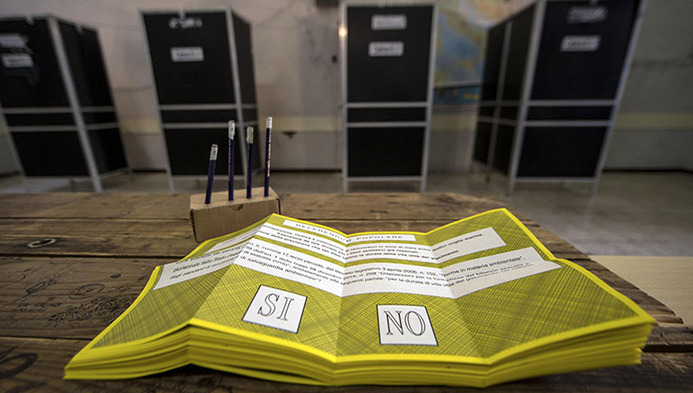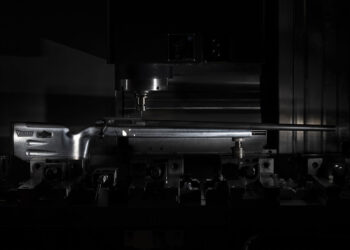Nel caldo sole di un pomeriggio di metà novembre mi trovavo al rientro a tordi insieme a Vincenzo. Non avevamo sparato molto quel giorno, e dal margine del bosco i pochi echi dei nostri spari si erano fermati almeno a una mezz’ora prima. Finalmente un tordo passa. E cade. Senza distogliere lo sguardo dal punto in cui crediamo di trovarlo camminiamo con passo felpato. I nostri occhi incontrano, a 10 metri da noi, quelli tondi, vacui, attoniti di una lepre. Un soggetto giovane, stava proprio lì al bordo del bosco.

Quando si accorge di noi si accuccia, come a volersi spalmare al suolo per rendersi meno visibile possibile. Le orecchie abbassate a lambire il dorso, immobile. Una preda perfetta, anzi, la preda peggiore. Inerme, indifesa, priva del giusto contesto di tracciatura e abilità dei segugi che fanno della lepre uno degli animali più affascinanti da cacciare. Eppure, il fucile carico, in spalla, chiede giustizia.

La nostra giustizia è questa lepre viva o, comunque, che non sia la vile fucilata di chi l’ha incontrata per caso a toglierle la vita. Questo animale non è un pezzo di carne, la selvaggina in generale secondo me non lo è. La dignità delle nostre prede, e la dignità stessa del cacciatore, come uomo, si sublima nella correttezza dell’azione di caccia in cui essi si confrontano.
Non so quanti, tra i miei conoscenti o tra chi legge, avrebbero lasciato che la lepre guadagnasse il bosco appena si fosse sentita sicura, come abbiamo fatto noi quel giorno.
La tentazione di sparare a un selvatico sicuramente sfiora tutti, ma mi chiedo: che gusto da sparare un capriolo in fuga mentre siamo di posta al cinghiale? O una beccaccia mentre siamo al rientro ai tordi? Il dito sul grilletto toglie una vita, ma la caccia non è morte.

La caccia è emozione, abilità, conoscenza, sacrificio. Immolare il nostro istinto da tiratori sull’altare del rispetto del selvatico è un grande sacrificio, ma è anche ciò che distingue il cacciatore dall’assassino.